Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino
Piazzetta Antonio Pasqualino 5, Palermo
Palermo, 19 – 20 aprile 2024
La SIAC riunisce le antropologhe e gli antropologi italiani impegnati nel mondo accademico e nella scena pubblica e sociale
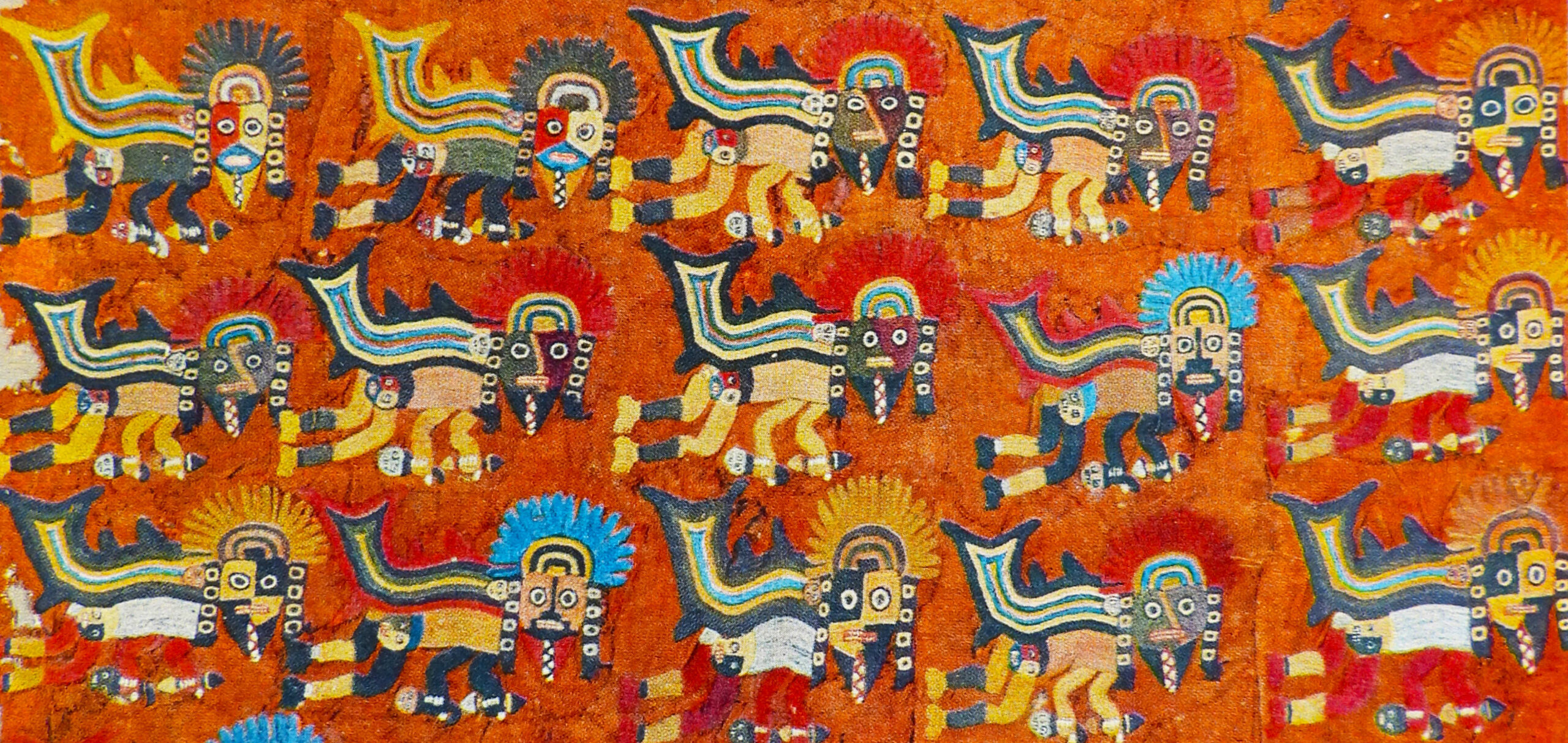
Memorie dell’alterita: gli archivi fotografici pubblici DEA in Italia. Consistenze, problemi, prospettive
RAC – Rivista di antropologia contemporanea Numero monografico 1/2025
Sinistre e popoli. Ripensare un rapporto inattuale
a cura di L. Urbano e A. Vesco
Deadline proposte: 20 maggio 2024
CfP “War and Peace as Challenges for Social Work and Social Pedagogy”
Annual Review of Social Work and Social Pedagogy in Austria (OeJS)
Deadline for Abstracts: 14 July 2024
2 Graduate Fellowships
Illicit Labour (ERC project) – Illicit labour and the photovoltaic industry
CNR-IRPPS
PI: Carlo Inverardi-Ferri
Deadline: 15 aprile 2024
Assegno annuale in M-DEA/01
Università di Firenze
Deadline: 2 Maggio 2024, ore 13:00
Bando per n. 12 assegni di ricerca Progetto “Un senso nel disordine. Praticare la complessita”
Dipartimento di Eccellenza Civiltà e Forme del Sapere
Università di Pisa
Razzismo e antirazzismo in Italia. Saperi e pratiche decoloniali attraversano l’università italiana
Presentazione numero monografico “From the European South” (12, 2023) a cura di Valeria Ribeiro Corossacz e Tatiana Petrovich Njegosh
Genitorialita in migrazione
Ciclo di seminari “Non è un paese per genitori”
Coordinato da Federica Tarabusi e Bruno Riccio

